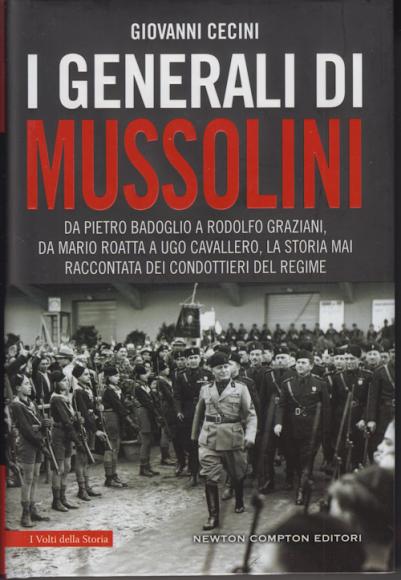Giovanni Cecini
Ed. Newton Compton
pagg. 538
Il ruolo dei militari di alto grado nel Ventennio è stato spesso analizzato, ma senza che le loro biografie fossero strutturate in modo sistematico; ben venga quindi questo studio di un giovane storico militare, il quale inquadra le figure di ben 37 generali di Mussolini (di ogni tipo: politici, condottieri, burocrati, monarchici, fascisti) in una cornice complessiva che ne individua le diverse personalità, ma anche le costanti, alcune delle quali tuttora dure a morire.
La guerra fu voluta dal Fascismo, ma avallata da generali in gran parte fedeli al Re. Perché di questo si tratta: la generazione degli ufficiali di S.M. che aveva vinto la prima G.M. si era chiusa in casta, mantenendo un esercito di caserma sovradimensionato, ostacolando le riforme e forgiando nella stessa mentalità anche i nuovi quadri, alcuni dei quali provenienti realmente dalla gavetta. La casta fu ben lieta di aderire al Fascismo – nato in fondo dalle trincee e ostile ai politici responsabili della Vittoria Mutilata – ma profondamente fedele al Re, il quale riuscì a liquidare gli squadristi e a mantenere sempre ai vertici i generali piemontesi, come Badoglio e Cavallero, e figure carismatiche come Amedeo duca d’Aosta o il principe Umberto: eroe e diplomatico il primo, un complessato obbediente il secondo. Roatta e Bastico erano filofascisti, ma pur sempre ufficiali di carriera; che l’Esercito fosse del Re lo dimostra da solo l’8 settembre: i reparti che per tre anni avevano combattuto su cinque fronti si sfaldarono in poche ore perché la struttura era diventata acefala.
Dal canto suo il Duce gestì bene l’immagine delle FF.AA., ma si guardò bene dal riformarle o modernizzarle sul serio, a parte le necessità imposte p.es. dalla motorizzazione. Fece di meglio con l’Aeronautica, essendo arma giovane; altrimenti i riformatori duravano poco; piuttosto, da un lato inserì ai vertici anche i suoi uomini (Balbo, Graziani, De Bono) e creò una serie di organi e comandi paralleli (vecchio vizio italico), in modo che la struttura di comando risultasse bilanciata e nessuno potesse realmente averne un controllo completo. Ma se un simile sistema di equilibri politici può andar bene in tempo di pace, in tempo di guerra diventa un suicidio. Guerra i cui obiettivi non furono mai strategici, ma politici, non ultima la concorrenza (patetica e/o tragica) con la Germania di Hitler. Ma pure questa è una costante, visto che neanche oggi la politica estera italiana riesce a definire con precisione gli interessi nazionali.
Lo storico inglese Denis Mack Smith ne Le guerre del Duce (1976) notava allibito che il Fascismo pensava solo alla guerra, ma non ha mai organizzato le risorse per farla bene.
Tutti i generali e i gerarchi erano coscienti per primi delle carenze dello strumento militare e industriale, ma speravano in fondo di cavarsela a buon mercato e di mantenere comunque i loro previlegi economici e politici. Le divisioni binarie sono un esempio da manuale: passare da tre brigate a due per ogni divisione moltiplicò il numero dei reparti e dei comandi, aumentando le possibilità di carriera e mostrando un’immagine di potenza numerica, ma di fatto creando grandi unità deboli sul campo perché prive di riserve, malamente integrate dalle Camicie Nere. Ma se le guerre in Libia, Albania, Abissinia e Spagna erano conflitti limitati, dopo il 1940 il bluff non poteva più reggere, col risultato di diventare vassalli dei Tedeschi invece che comprimari, e di portare l’Italia a una rovina dalla quale non si è più rialzata, almeno come potenza regionale indipendente. Ma in questo disastro i generali italiani hanno avuto la loro responsabilità, accettando una guerra moderna ben sapendo di non essere preparati a combatterla e alimentarla in condizioni realistiche, su fronti troppo estesi e scollegati da una strategia complessiva. Quando poi la situazione è precipitata, hanno allegramente creduto di poter eliminare il Duce, fregare i Tedeschi e poter negoziare alla pari una pace separata con gli Alleati, come se Eisenhower fosse disposto a capire le doppiezze rinascimentali di Ambrosio e Badoglio o Kesselring fosse un cretino.
Alcuni generali valevano sicuramente qualcosa sul campo – Messe, Gariboldi, Baldissera - come pure anche alcuni burocrati, penso a Grazioli e Baistrocchi o al meno noto Favagrossa. L’insieme però è desolante: se Graziani e Balbo erano fascisti, gli altri non lo erano, ma nessuno di loro ha mai alzato la voce o sbattuto la porta davanti al Duce; se l’ha fatto, era tardi. Ma il prezzo l’hanno pagato gli italiani: non solo i soldati caduti sul campo o internati in Germania, ma anche la popolazione civile. Quasi tutti i generali hanno poi riempito estesi memoriali per dichiararsi vittime del Fascismo o screditare i colleghi. Nessuno è stato mai estradato nei paesi dove aveva compiuto crimini di guerra. In più, l’8 settembre del ‘43 in troppi hanno abbandonato i soldati a se stessi. L’esercito poi si riscattò quasi da solo, ma facendo a meno di molti suoi generali.
L’autore si ferma al 1945, ma è interessante analizzare anche i risultati di lungo periodo. Per anni gli italiani avrebbero avuto scarsa stima dei propri militari, continuando il mito della Grande Guerra ma sorvolando sulla seconda o esaltandone le gloriose sconfitte (El Alamein!). Gli Alleati dopo la guerra puntarono ad acquisire basi militari, ma senza incidere nella sostanza: mentre riformarono l’esercito tedesco, in Italia ricostruirono l’esercito che c’era prima, modernizzandone la struttura materiale e adeguando la formazione dei giovani ufficiali agli standard NATO, ma senza imporsi per cambiare la mentalità e le abitudini dei vertici.
I partiti politici del dopoguerra dal canto loro non hanno mai espresso salvo rari casi gente competente in materia militare, quindi i vertici in divisa rimasero se non una casta, sicuramente un gruppo chiuso e autoreferente. Alcuni ex generali si lanciarono in carriere politiche di alterna fortuna e qualcuno ci prova ancora adesso. L’industria continuò a condizionare le forniture militari e i sistemi d’arma; le promozioni ai vertici di S.M. avrebbero risentito comunque degli equilibri di governo; la burocrazia rimase sproporzionata, sottraendo risorse all’addestramento ma garantendo a tutti il posto fisso a rischio zero, visto lo stallo imposto dalla Guerra Fredda.
Solo alla fine degli anni ’60 la mentalità conservatrice dei militari avrebbe cozzato con una società ben più avanti del suo esercito, distruggendo equilibri consolidati e mettendo in crisi il rapporto tra i cittadini e le proprie istituzioni militari. Ciò avvenne anche altrove, ma in Italia i problemi venivano da lontano.
Marco Pasquali